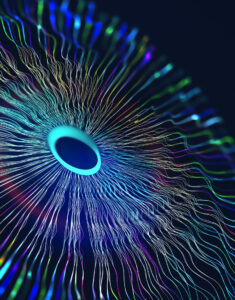Cina e Stati Uniti in Medio Oriente
 La Cina sta diventando un “animale politico”, con l’obiettivo di ricoprire un ruolo a livello internazionale. Ciò sta avvenendo anche in Medio Oriente, una regione, di fatto, sotto l’influenza degli Stati Uniti. È in questi termini che ne parla Enrico Fardella, professore associato presso l’Università di Napoli “LOrientale” e direttore del progetto ChinaMed.it.
La Cina sta diventando un “animale politico”, con l’obiettivo di ricoprire un ruolo a livello internazionale. Ciò sta avvenendo anche in Medio Oriente, una regione, di fatto, sotto l’influenza degli Stati Uniti. È in questi termini che ne parla Enrico Fardella, professore associato presso l’Università di Napoli “LOrientale” e direttore del progetto ChinaMed.it.
Stati Uniti, Cina e Medio Oriente: quali sono le dinamiche che si stanno sviluppando?
«Vorrei fare una premessa. La politica internazionale, sia dal punto di vista dell’analisi, sia da quello dell’implementazione, è sempre qualcosa di molto più complesso di quanto non si possa pensare: non deve essere banalizzata in facili semplificazioni tra amici e nemici. Guardando ai paesi del Medio Oriente, partendo da un’analisi macro, si può affermare che erano diventati pezzi di una regione che gli Stati Uniti avevano di fatto inventato, costruito e determinato in diretta opposizione all’Unione Sovietica. La chiusura della Guerra fredda sancì la fine del bipolarismo e si passò all’unipolarismo guidato dagli Usa, mentre la Cina iniziò a svolgere una funzione fondamentale all’interno della cosiddetta pax americana, un passaggio il cui traghettatore, alla fine, fu lo stesso Mao Zedong. Pechino decise allora di partecipare, in modo intelligente, a quell’ordine liberale voluto da Washington per ottenere il meglio ed evitando di subirne il peggio. Alla fine degli anni settanta, la Cina decise di diventare il centro produttivo del nuovo sistema economico globale, attraendo capitali e know how occidentali e diventando il core di un nuovo sistema di approvvigionamento industriale. Ciò le permise di divenire il perno del processo di globalizzazione sostenuto finanziariamente dagli Stati Uniti. Questa è stata la struttura che ha consentito alla Cina di diventare sempre più rilevante all’interno dell’ordine la cui pace e sicurezza erano garantite dall’egemonia americana. Il sogno cinese, così come viene chiamato oggi, è stato foraggiato e sostenuto dall’appoggio dei capitali e dell’esercito statunitense. Contemporaneamente alla sua crescita all’interno dell’ordine economico internazionale, la Cina familiarizzava sempre più con le nazioni con le quali veniva in contatto: fu un processo che iniziò a partire dagli anni novanta, conobbe un crescendo del decennio successivo sino a raggiungere l’apoteosi della proiezione cinese all’estero nel 2013, con l’annuncio della Belt and Road Initiative (Bri). Quest’ultima non fu una creazione ex nihilo, bensì lo sbocco di un processo già in corso, con l’obiettivo di organizzare, espandere e rafforzare un sistema di catene di fornitura resistente, incentrato sulla Cina e che abbracciava il mondo eurasiatico, includendo anche l’Africa».
È quindi un processo in atto ormai da parecchi anni?
«È stato un processo che ha conosciuto diverse fasi, tra le quali quella caratterizzata dall’export, che mostrò però diversi limiti nel momento in cui da alcuni paesi venne percepita come un’azione di dumping distruttivo nei confronti della manifattura domestica. Progressivamente, da questo periodo si passò a un altro in cui la presenza cinese, attraverso appunto la Bri, si manifestò con la realizzazione di infrastrutture funzionali, soprattutto legate alla creazione di reti ferroviarie, con un ruolo anche di stabilizzazione di province periferiche, quali lo Xingiang: fu un modo di controllare pacificamente queste regioni di confine per renderle più dipendenti dalla governance industriale di Pechino. Tuttavia, poiché il 90% del commercio internazionale passa via mare, la Cina iniziò a investire in infrastrutture portuali, funzionali all’assorbimento del proprio export, ma, allo stesso tempo, anche nei paesi dove venivano realizzate, che altrimenti non avrebbero avuto la capacità di essere connessi al commercio internazionale. Dal ’95 in poi, il Medio Oriente diventò il fornitore principale di idrocarburi per la Repubblica Popolare, che ivi esporta le sue merci. Si creò, così, un flusso di valore che passava perlopiù attraverso l’Oceano Indiano, controllato dalla marina militare americana, creando una delle nervature più importanti della globalizzazione come è stata conosciuta sino al 2013».
La Cina è così riuscita a creare una nuova area di influenza economica?
«La Cina è riuscita, in questo modo, ad allargare la propria influenza economica nel Medio Oriente, creando un nuovo canale, che alcuni hanno chiamato del petro-yuan, attraverso il quale il potenziale energetico della regione veniva orientato verso l’Asia orientale, in particolare i porti cinesi. Ciò permise di rafforzare, sia economicamente, sia finanziariamente, i legami con l’élite dei paesi del Golfo. Avvenne così che, gradualmente, il baricentro delle relazioni internazionali mediorientali si spostò sempre più a oriente e coinvolse paesi quali la Turchia, l’Arabia Saudita, gli Emirati Arabi e Israele. Gli anni dal 2015 al 2018 sono stati quelli in cui la Repubblica Popolare Cinese è stata particolarmente attiva nell’attrarre l’interesse della classe politica ed economica mediorientale. Per dare alcuni riferimenti temporali, proprio nel 2015 l’Arabia Saudita divenne il primo fornitore di idrocarburi della Cina. Quest’ultima iniziò i propri investimenti in modo articolato all’interno della filiera energetica e sviluppò rapporti sempre più sinergici con le autorità locali, ricoprendo un importante ruolo di sostegno al piano di trasformazione economica del paese, il cosiddetto Vision 2030, su un modello di industria 4.0. Ciò fu possibile grazie alle competenze che la Cina, ormai non più vista come la manifattura a basso valore aggiunto del mondo, poteva offrire in termini, sia di innovazione, sia di tecnologia. Nonostante questa evoluzione, la famiglia regnante saudita ha sempre continuato a mantenere relazioni politiche, economiche e militari con gli Stati Uniti, in continuità con il tradizionale legame storico collegato alla sicurezza nell’area».
Quindi siamo di fronte a un’Arabia Saudita in cerca di un equilibrio tra due superpotenze?
«Direi che è un atteggiamento che mira a bilanciare le diverse relazioni: il vecchio e tradizionale rapporto di sicurezza economica e militare con l’occidente da un lato e la forza economica cinese dall’altro. Una politica, quest’ultima che, in qualche modo, e là ove possibile, viene replicata da quel gruppo di paesi con economie in via di sviluppo (Global South). Si tratta di un tentativo di uscire dal passato per guardare a un futuro più equilibrato, dove potere fare emergere la propria indipendenza, come nel caso dell’Arabia Saudita, che, oserei dire, nel bilanciare i rapporti con le due superpotenze e fare emergere, nel contempo, la propria posizione, è riuscita a compiere una manovra ardita».
Il progetto che sottostà alla Bri è cambiato negli anni?
«Sì, esattamente nel 2017, con il XIX Congresso del Partito comunista cinese (Pcc), dal quale emersero una funzione della Bri sempre più revisionista del sistema internazionale e l’idea che la Cina avrebbe potuto svolgere il ruolo di scardinatore dell’ordine liberale, considerato squilibrato e ingiusto: era addirittura ritenuto una minaccia per l’esistenza e la sopravvivenza della Repubblica Popolare e del monopolio del Pcc. Fu proprio questa rivisitazione della Bri che produsse una reazione americana, durante l’amministrazione Trump, che cominciò un’operazione di critica e di contenimento delle avance cinesi sul fronte eurasiatico. Non è forse un caso che, nel 2019, la stessa Ue, per la prima volta, nel documento ufficiale sulla politica cinese, inserì la definizione “rivale sistemico”, riferendosi appunto alla Cina, che veniva così considerata non più una potenza regionale con interessi globali, bensì una potenza globale con ambizioni globali. In quest’ottica, la Bri veniva percepita come una leva con cui la Terra di mezzo avrebbe potuto scardinare l’ordine liberale e, per questo motivo, era considerata una minaccia da parte di quei paesi che in questo ordine si riconoscevano».
Da questo punto di vista, il Global South come considera la Cina?
«In linea di massima, cerca di capitalizzare sulla nuova forza cinese, tanto quanto la Cina tenta di farlo sul Global South, per provare a essere più forte e indipendente rispetto alla forza economica e politica occidentale, soprattutto americana. È l’ottica della diversificazione, che rende il potere contrattuale di una nazione più solida, proprio perché ci sono più offerenti. Siamo in un mondo che assomma in sé due caratteristiche di fatto antitetiche: unipolarismo e multipolarismo. Gli Stati Uniti rimangono il dominus mondiale, ma devono gestire la propria egemonia in un sistema in cui ci sono tanti altri nuovi poli e la distribuzione del potere è molto più varia rispetto a quanto non successe dopo la fine della guerra fredda. Ciò rende il tutto più complesso rispetto al passato, perché gli allineamenti tra paesi non sono costruiti a priori e vengono determinati dalle convenienze contingenti. In sintesi, direi che il Global South vede la Cina come un’opportunità, che deve essere colta senza che ciò comporti un assoggettamento o una dipendenza, né si nutre dell’ideologia del Partito comunista cinese. Questa opportunità è finalizzata al rafforzamento della posizione del singolo paese, senza però comprometterne l’indipendenza in un mondo sempre più complicato, magari cercando di acquisire maggiore potere contrattuale o vantaggi nell’allinearsi su un fronte piuttosto che su un altro. Il corollario principale della politica anti-egemonica cinese è il rafforzamento dell’indipendenza. In generale, si può affermare che, più paesi indipendenti ci sono nel Global South, minori sono le possibilità egemoniche degli Stati Uniti e ciò si traduce, ipso facto, in una difesa proattiva da parte cinese. Per quanto riguarda il caso specifico del Medio Oriente, sebbene la regione e la Cina siano legati a doppio filo, entrambi sono consapevoli di come possano differire le interpretazioni dei ruoli vicendevolmente ricoperti e dei possibili rischi per il futuro delle loro relazioni».
Il mondo occidentale, Stati Uniti in primis, esce da questo contesto ridimensionato?
«Il mondo occidentale da tempo sta conoscendo questo processo di ridimensionamento. Tuttavia, è opportuno fare una precisazione. Se la considerazione è legata al mondo occidentale liberale, sostenuto soprattutto da Europa e Nord America, va detto che si sta parlando di un ordine che ha una sua intelligenza intrinseca, voluto e creato in modo particolare dalla forza degli Stati Uniti, cui la Cina vorrebbe somigliare, ma non riuscirà mai a farlo. La ragione di questa affermazione è che Pechino non ha gli strumenti per adeguarsi a un sistema di conto capitale (capital account) e di egemonia economico-finanziaria come quelli americani. Anzi, al contrario, soffre del fatto di essere un paese in declino, perché non ha la capacità di affrontare quelle trasformazioni strutturali necessarie per potersi trasformare in un rivale credibile a livello internazionale e alternativo agli Usa. Non lo può fare perché non è dotata di una struttura adeguata. Se la Cina è nota per il controllo dei capitali, come può diventare il cuore dell’internazionalizzazione con lo yuan come divisa di riferimento? Come è possibile che ciò avvenga, se la maggior parte dei settori economici cinesi è preclusa agli investimenti esteri?»
Tuttavia, i progressi fatti in questa direzione dalle autorità cinesi sono stati importanti, non trova?
«La logica dell’apertura della Cina, iniziata alla fine degli anni settanta, non è quella attuale ed esiste una profonda diversità tra i due contesti storici. Il Paese non è in guerra con gli Stati Uniti, bensì con sé stesso. Se la Cina di oggi fosse in linea con le logiche che hanno ispirato l’apertura voluta da Deng Xiaoping, probabilmente la situazione sarebbe diversa: si è di fronte a uno stato che ha fatto suo un modello economico “sviluppista”, che reprime i consumi e alloca risorse sul lato dell’offerta e importa capitali, grazie all’export, creando vere e proprie cancrene da un punto di vista, sia politico, sia economico. Sono anni, ormai, che la Cina parla di aumentare i consumi interni, ma non ci sta riuscendo, perché si è creata un’élite economica e politica che beneficia di questo sistema completamente squilibrato, che produce un’offerta eccessiva e che genera investimenti non produttivi. È dalla dipendenza dalle esportazioni che nasce l’instabilità del modello economico cinese, che per crescere deve continuamente produrre debito. Sono convinto che, nei prossimi anni, il problema non sarà gestire la crescita cinese, perché il Paese dovrà fare i conti con la sostenibilità del proprio modello economico e con la conduzione dei rapporti tra la leadership politica e la popolazione».
Come bisogna allora guardare alla Cina?
«Non solo come una protagonista in ambito economico, cosa che forse poteva valere sino a 10 anni fa, ma come un “animale politico” che ha un obiettivo trasformativo a livello internazionale. Il salto consistente, in questa direzione, è stato fatto da Xi Jinping, che ha trasformato il rapporto simbiotico tra Cina e occidente e ha assunto una posizione sfidante nei confronti di quest’ultimo, secondo una logica marxista che conferma sé stessa e produce miraggi».
In che senso?
«Nel momento in cui si è convinti (la Cina) che l’occidente è in declino, ne deriva che l’oriente è in ascesa e la Cina, a sua volta è determinante perché ciò avvenga con una logica marxista».
Ma ciò è accaduto a causa dell’attuale leadership?
«Non lo so, non penso che ciò si possa affermare in modo netto. La mia impressione è che ci sia un combinato disposto molto pericoloso tra le parti più schizofreniche della politica americana e di quella cinese, che rischia di creare alcuni corti circuiti, controproducenti per entrambi i paesi. L’Europa, non ha le capacità di correggere questi meccanismi perversi e, quindi, ci si ritrova tutti assorbiti dalla spirale di sicurezza che preclude a un futuro non roseo. Non sto paventando un conflitto a livello mondiale, non ci credo, ma l’ideologia può essere sorprendente per ciò che riesce a produrre».
Se l’obiettivo della Cina fosse perseguire obiettivi politici e non solo economici, allontanando sempre più una parte del mondo dall’influenza Usa, che cosa potrebbero fare gli Stati Uniti?
«Ci sono due scenari estremi. Il primo è rappresentato da un conflitto militare, il secondo dalla desistenza, che può avvenire attraverso un cambio di leadership nelle due nazioni. Allo stato attuale delle cose, le relazioni tra Cina e Stati Uniti si stanno sempre più militarizzando, con lo stretto di Taiwan che è il punto di frizione e di crisi della relazione. È vero che, in tale contesto, l’America si muove con estrema prudenza, senza esporsi in prima persona, ma utilizzando i propri alleati per evitare uno scontro tra giganti. L’unica via d’uscita di questa situazione è che ci possa essere un conflitto militare limitato (come successe nel 1969 tra Cina e Urss) per aprire i tavoli di una trattativa diplomatica. La seconda, invece, è appunto un cambio della leadership, sia negli Usa, sia nella Repubblica popolare cinese. Nel primo caso, una vittoria dei repubblicani potrebbe portare Washington a ridimensionare la propria sovraesposizione globale, per concentrarsi più sulla propria regione. Nel secondo, invece, si potrebbe assistere a una messa in minoranza della leadership del partito di Xi Jinping. Sarebbe possibile anche una terza alternativa, come alcuni ipotizzano, di natura finanziaria: gli Usa potrebbero introdurre una tassazione sugli investimenti speculativi cinesi (ma non solo) nel paese, minando così la centralità del dollaro, ma creando seri danni alla Cina e al suo modello di crescita».