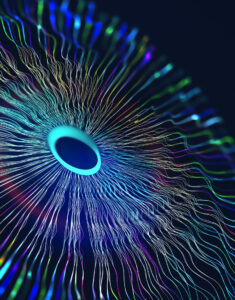«M&A: uno strumento per la crescita delle PMI»
A colloquio con Simone Citterio, Head of Corporate Finance Advisory di Banca Euromobiliare
Oltre 45 anni di storia a fianco delle famiglie imprenditoriali italiane: qual è l’importanza di essere così vicini al tessuto produttivo del Paese?
 «La presenza costante vicino agli imprenditori ci consente di capire velocemente le necessità di chi guida un’azienda, di individuare le possibili soluzioni e di fare in modo che siano compatibili con le regole del mercato. Le imprese famigliari hanno caratteristiche ricorrenti e simili, indipendentemente dal settore in cui operano o dalla dimensione del loro fatturato. Talvolta ciò che proponiamo è lontano dall’idea iniziale che l’imprenditore aveva in mente, spesso suggerita da consulenti o investitori che conoscono poco il mondo delle Pmi, ma la nostra ricetta funziona perché l’abbiamo già utilizzata nelle precedenti operazioni».
«La presenza costante vicino agli imprenditori ci consente di capire velocemente le necessità di chi guida un’azienda, di individuare le possibili soluzioni e di fare in modo che siano compatibili con le regole del mercato. Le imprese famigliari hanno caratteristiche ricorrenti e simili, indipendentemente dal settore in cui operano o dalla dimensione del loro fatturato. Talvolta ciò che proponiamo è lontano dall’idea iniziale che l’imprenditore aveva in mente, spesso suggerita da consulenti o investitori che conoscono poco il mondo delle Pmi, ma la nostra ricetta funziona perché l’abbiamo già utilizzata nelle precedenti operazioni».
Quali sono le caratteristiche delle imprese con cui avete consolidato una relazione?
«Innanzitutto aziende sane. Poi gestite da imprenditori e manager che lavorano con l’obiettivo di migliorarsi giorno dopo giorno e di puntare sempre a battere il proprio record. Le società con cui abbiamo collaborato in tutti questi anni hanno saputo imprimere una nuova fase di crescita dopo l’operazione straordinaria fatta insieme, espandendo fatturato, redditività e organici; talvolta hanno anche fatto acquisizioni e oggi il patrimonio aziendale in senso lato è aumentato, è più solido e difendibile».
Avete un profilo specifico delle aziende che rientrano
nel vostro target cliente?
«Sì. Per i mandati di cessione (100%, maggioranze o minoranze) l’identikit è costituito da imprese in utile, prevalentemente a capitalismo famigliare e con fatturati compresi tra 30-300 milioni. Possiamo fare eccezioni per società con volumi d’affari minori, purché con redditività o tassi di crescita superiori alla media».
Qual è il vostro punto di forza all’interno della consulenza aziendale che offrite?
«Siamo meticolosi nel preparare l’operazione. Non presentiamo un’azienda al mercato finché non abbiamo concordato con tutti gli azionisti, dai più importanti a quelli marginali, la struttura dell’operazione, le quote da cedere, le valutazioni attese e la tipologia del partner (industriale o finanziario). Operare così richiede un maggiore sforzo ma, quando invitiamo i compratori, questi sanno che non perderanno tempo perché il deal è pronto da consumare. Sul mercato arrivano spesso proposte dove non è chiaro che cosa cerca l’imprenditore, con il rischio di allungare i tempi e di fare confusione. Secondo, siamo riservatissimi: ci muoviamo nei contatti come un sommergibile ai tempi in cui i sonar non esistevano. Quando il pubblico viene a sapere di un’operazione conclusa da noi (per “pubblico” intendo fornitori, clienti, maestranze, eccetera), il nostro cliente ha già fatto il closing ed è lui stesso a comunicarla a tutti coloro che hanno un interesse nella società. Non condivido il comportamento di far trapelare indiscrezioni durante il processo per facilitare la ricerca dei buyer: in questo modo la famiglia si trova a gestire inutili stress, perché il sistema che ruota intorno all’azienda è allarmato dalle voci sul mercato. Inoltre, se l’impresa non si vende, i cocci restano in mano all’imprenditore. Terzo: diciamo la verità, anche se a volte può essere difficile da accettare e poco gradita. Anni fa abbiamo incontrato una famiglia per un possibile incarico. L’azienda era splendida dal punto di vista di performance e brand, ma spaccata in due a livello di rami famigliari: erano tutti stanchi e stufi, non c’erano manager e mancavano strumenti di pianificazione e reporting. Inizialmente volevano assistenza per la quotazione in Borsa perché altre banche d’affari avevano proposto un’Ipo con valutazioni iperboliche. Peccato che l’azienda necessitava di anni per avere i requisiti minimi per accedere al mercato dei capitali e in quel lasso di tempo la lacerazione tra soci avrebbe portato al declino della società in mancanza di una guida unitaria. Nessuno aveva messo in guardia gli imprenditori, la Borsa era il formaggio sull’amo per prendere l’incarico e poi stare a vedere. Abbiamo impiegato un po’ di tempo per smontare questa favola, hanno capito che il progetto non era fattibile e abbiamo realizzato di lì a un anno la cessione del 100% con grande soddisfazione per i soci e gli stakeholder aziendali».
Ha alcuni esempi di imprese che hanno tratto vantaggio dall’avervi al loro fianco?
«Faccio due esempi, uno di apertura del capitale e uno di acquisizione. Il primo è Club del Sole, leader italiano nel comparto dei camping village: quando li abbiamo incontrati, avevano il sogno di seguire l’esempio dei grandi gruppi europei con fatturati a tre cifre di milioni, managerializzati e aggreganti. Esaminata la situazione di partenza come azienda e famiglia, abbiamo proposto una soluzione di M&A che prevedeva di raccogliere i capitali per lo sviluppo senza cedere il controllo e innestare nella società un salto di mentalità e di managerializzazione. Selezionato tramite un’asta mirata un socio finanziario non invasivo che ha sottoscritto un aumento di capitale, è stata rafforzata la struttura manageriale, sono entrati nel consiglio di amministrazione consiglieri indipendenti e in poco più di tre anni sono state realizzate cinque acquisizioni. Risultato: il fatturato è raddoppiato e l’Ebitda è aumentato del 62%. Dopo questa fase di crescita ambiziosa, abbiamo nuovamente avviato la ricerca di nuovi partner finanziari per dare il cambio ai soci di minoranza e raccogliere nuovi capitali per lo sviluppo. Il secondo esempio è un caso di acquisizione con il Gruppo Cartiera dell’Adda. La famiglia Cima, in sella da due generazioni, conosceva tutti gli operatori a livello europeo, purtuttavia siamo riusciti a intercettare l’acquisizione di un concorrente individuato tramite il nostro network e lo abbiamo prontamente segnalato alla famiglia. Siamo stati bravi e fortunati a trovare un’acquisizione pronta, ma è stato bravissimo l’imprenditore a battere gli altri compratori in asta; noi lo abbiamo supportato nel processo di M&A e nel reperimento dei finanziamenti per ottimizzare la struttura finanziaria. La soddisfazione è di avere contribuito a fare nascere uno dei maggiori gruppi del comparto con un fatturato di oltre 100 milioni, raddoppiando il giro d’affari in 12 mesi. Questo è il valore aggiunto che ci piace creare per i nostri clienti: presentare operazioni complementari che non erano venute loro in mente, aiutare a concretizzarle e a scalare posizioni che solitamente necessitano di molti anni, senza mettere a rischio la solidità aziendale».
C’è chi sostiene che la troppa parcellizzazione rappresenti un punto debole all’interno del sistema produttivo. Che cosa ne pensa?
«È arrivato il momento di sfruttare il patrimonio delle Pmi facendole evolvere in un modello in cui coesistano i punti di forza del capitalismo famigliare con quelli delle aziende aperte al mercato dei capitali. In pratica, vorrei vedere introdotti anticorpi per rendere queste aziende, che hanno già fatto un lavoro fantastico per il Paese, ancora meno vulnerabili. Come anticorpi intendo l’inserimento di manager capaci (anche con piccole quote di partecipazione) e di bravi professionisti indipendenti nei consigli di amministrazione, la realizzazione di piani di incentivazione legati ai risultati a medio termine estesi a tutti i portatori di interesse in azienda, la creazione di cultura della pianificazione a medio termine, una maggiore penetrazione nei mercati internazionali. Ove possibile, anche l’apertura del capitale a investitori pazienti di private equity, opportunamente selezionati, che possano svolgere una preziosa attività di accompagnamento in tutti i cicli di sviluppo. Mi piacerebbe tra 10 anni vedere più aziende dove le famiglie controllano la maggioranza, anziché il 100%, ma con dimensioni maggiori, più performanti, più internazionali, più managerializzate: in una parola, ancora più solide per affrontare le sfide future. Guardando le storie delle famiglie che abbiamo assistito, noto a posteriori tassi di crescita eccellenti che non sarebbero stati possibili senza l’ingresso dei nuovi soci».
Il mercato italiano è oggetto di interesse per le aziende straniere, nonostante la sua complessità. Come vede questo trend a tendere?
«Continuerà. Innanzitutto perché l’Italia presenta una miriade di società eccellenti che hanno un vuoto generazionale in quanto non ci sono i figli naturali, ovvero ci sono, ma hanno deciso di fare altro. In altri casi ci sono aziende che hanno brand o competenze storicamente eccellenti, ma sono entrate in difficoltà perché non sono state capaci di adattarsi alla nuova competizione. È probabile che queste imprese finiscano in mani estere, tenuto conto che i gruppi stranieri hanno taglie dimensionali che consentono di fare M&A più facilmente e che le società italiane predatrici hanno più bisogno di crescere all’estero che non di acquistare ottimi target domestici poco esportatori. È un’ovvietà, ma ben venga per il benessere di tutti che un’eccellenza italiana prosegua la crescita anziché scomparire, indipendentemente dalla nazionalità del compratore».
Vede il rischio di una “colonizzazione” e di un impoverimento dell’eccellenza imprenditoriale italiana e più in generale del tessuto produttivo del nostro Paese?
«Il vero impoverimento è quando la proprietà di un’azienda smette di investire risorse, fare progetti, immettere capitali nella propria impresa che diventa solo una fonte di reddito. Poiché di rendite di posizione ce ne sono sempre meno e un simile atteggiamento porta solo al declino, molto meglio che arrivi uno straniero a tenere accesa l’eccellenza investendo capitali, creando posti di lavoro e facendo ricerca e sviluppo. Da italiano mi spiace solo che abbiamo pochi colossi che possano fare da aggregatori, a differenza delle conglomerate private straniere».
Dal suo osservatorio, quali pensa che siano i punti di forza e quelli di debolezza delle imprese italiane?
«Non voglio generalizzare, ma le indico una situazione di debolezza che mi colpisce sempre quando la trovo. È la paura da parte di taluni imprenditori di delegare, di crearsi un alter ego. Queste persone, peraltro molto intelligenti, ritengono che non ci sia nessuno in grado di gestire bene come loro, né figli, né manager. La conseguenza è che i manager bravi si rendono indisponibili oppure se ne vanno via: intorno all’imprenditore rimangono personalità medie in ruoli marginali, pronte a dire sempre di “sì”, lasciando il leader solo e l’azienda pericolosamente dipendente dalla sua figura. E poi poca meritocrazia. Per contro, gli imprenditori italiani hanno la capacità di districarsi in situazioni complesse come pochi al mondo. Sono abituati da sempre a lavorare con le proprie forze senza nessun aiuto dallo Stato, dalle infrastrutture, dalla politica. Rispetto ai colleghi stranieri hanno molta più inventiva e creatività. In tutti i casi di acquisto di aziende all’estero dove ho lavorato con loro, ho visto imprese integrate e rilanciate nel giro di poco tempo e ho sempre pensato che i nostri imprenditori, a furia di essere abituati in Italia a muoversi in mezzo a burocrazia, tassazioni elevate e rigidità normative, appena trovano situazioni di gestione più normali e possono concentrarsi sul business, non li ferma più nessuno».