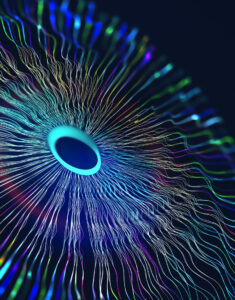Un kaizen guy
 Pierluigi Tosato è un manager e un imprenditore con una lunga esperienza alle spalle, che ha lavorato in aziende nel settore industriale tra cui Interpump Cleaning, Global Garden Products, Continental Bakeries, Acqua Minerale San Benedetto e Bolton Alimentari. Di recente è stato chiamato a gestire le attività in Italia di Bouvard International, uno dei tre maggiori produttori di biscotti in Francia. Manager samurai, come ama definirsi, nello svolgimento della sua attività ha fatto proprio il metodo kaizen, che è diventato non solo un modo per cambiare un’azienda, ma anche un approccio alla vita.
Pierluigi Tosato è un manager e un imprenditore con una lunga esperienza alle spalle, che ha lavorato in aziende nel settore industriale tra cui Interpump Cleaning, Global Garden Products, Continental Bakeries, Acqua Minerale San Benedetto e Bolton Alimentari. Di recente è stato chiamato a gestire le attività in Italia di Bouvard International, uno dei tre maggiori produttori di biscotti in Francia. Manager samurai, come ama definirsi, nello svolgimento della sua attività ha fatto proprio il metodo kaizen, che è diventato non solo un modo per cambiare un’azienda, ma anche un approccio alla vita.
Qual è la sua storia professionale?
«Ho una lunga esperienza come ceo di aziende multinazionali e anche come imprenditore, perché ho spesso investito nelle società che ho guidato. Ho lavorato prevalentemente con i fondi di private equity internazionali e, negli ultimi 15 anni, la mia attività si è concentrata nel settore alimentare (nello specifico in quello del food & beverage). Italia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Svezia sono le nazioni in cui ho vissuto in periodi diversi della mia vita; penso di aver visitato oltre 80 paesi nel mondo e parlo nove lingue. Come si può dedurre da quanto descritto, ritengo di avere un profilo internazionale che mi ha permesso di svolgere la professione in contesti diversi, mantenendo sempre l’apertura e la flessibilità necessaria per comprendere le dinamiche del mercato di riferimento. Nella gestione delle aziende, applico da sempre la metodologia kaizen, la filosofia di business alla base dei successi dell’industria nipponica negli anni ‘80 con particolare riferimento alla Toyota: si tratta del sistema di miglioramento continuo ideato da Masaaki Imai, da me considerato un maestro. Ciò che faccio, quando assumo la guida di un’impresa, è “toyotizzarne” la gestione».
Lei ha scritto anche un libro, a questo proposito. Di che cosa si tratta?
«Alcuni anni fa ho scritto “Samurai Manager. La montagna inaccessibile”. La decisione è nata dal fatto che Masaaki Imai mi aveva insegnato quanto fossero antiche le radici del kaizen e io le ho identificate all’interno del bushido, il codice di condotta dei samurai. L’ opera è anche un compendio di consigli agli addetti ai lavori, cui si aggiungono racconti legati a momenti particolari della mia vita da imprenditore».
Ma il metodo kaizen continua a essere attuale?
«Ritengo che lo sia sempre di più, indipendentemente dal momento storico odierno, perché fa fare un salto di livello alle aziende che lo applicano. È un metodo bottom-up che richiede tempo per essere realizzato e un cambiamento culturale a tutti i livelli organizzativi all’interno di un’impresa. Detto ciò, una volta implementato il metodo kaizen, l’effetto è a palla di neve e permette di raccogliere frutti significativi, perché migliora notevolmente il livello cui un’impresa opera».
Come ha coniugato le diversità dei paesi e dei mercati in cui ha operato con la sua attività manageriale?
«Uno dei vantaggi che ho avuto nella mia vita è di non avere una formazione culturale molto caratterizzata. Infatti, ho sempre cercato di prendere il meglio da tutti i contesti con cui mi sono dovuto confrontare e ciò mi ha permesso di avere un’educazione laica, che ha facilitato l’approccio a realtà tra loro molto diverse. Avendo abbracciato il metodo kaizen, sono partito dal suo principio di base: non giudicare nessuno. Sono così sempre stato aperto alle diversità culturali, grazie anche a una grande facilità di apprendimento delle lingue straniere. Mi definisco un camaleonte: non ho dogmi cui fare riferimento e mi adeguo al contesto del paese in cui vivo e opero. Questo atteggiamento mi ha permesso di abbassare il livello di resistenza al cambiamento e allontanare i pregiudizi che un italiano all’estero può suscitare, dandomi così la possibilità di comunicare direttamente con le persone con cui mi interfaccio. Bisogna capire che, per fare business e farlo con successo, è fondamentale comprendere la cultura degli altri paesi. Conoscere le lingue è uno strumento essenziale per rompere le barriere che si frappongono tra gli individui, perché facilita la comunicazione e la comprensione reciproca per potere interagire al meglio. Gli approcci ai mercati sono diversi a seconda della nazione in cui ci si trova e bisogna adattare, di conseguenza, la comunicazione e lo stile gestionale, avendo sempre lo stesso obiettivo kaizen che è migliorare continuamente il processo per ottenere ottimi risultati. Ribadisco, bisogna conoscere il Paese in cui si opera: se in Germania occorre dare ordini ben precisi per essere riconosciuto come capo, nei Paesi Bassi è fondamentale riunire le persone e ascoltare l’opinione di tutti e il manager deve ricoprire una funzione di supporto, creando consenso politico. Il mio vantaggio è sempre stato di non avere una forte cultura identitaria».
Come interpreta le nuove dinamiche presenti sul mercato che sembrano volere porre fine al fenomeno della globalizzazione?
«È un tema che mi tocca profondamente. Appartengo a una generazione cresciuta con la globalizzazione, che ho cavalcato e mi ha permesso di conseguire successi significativi. Mi sarei addirittura immaginato un’evoluzione ancora più spinta della situazione, con la realizzazione degli Stati Uniti d’Europa e la Russia integrata all’interno dell’Unione Europea. Ora mi trovo in una realtà dove tutto ciò che ho vissuto viene messo in discussione e sta andando a pezzi: la fine della globalizzazione per me è una grande sofferenza, perché mai mi sarei immaginato di trovarmi in una situazione mondiale come quella attuale. Le cose sono cambiate profondissimamente e ritengo che il picco della globalizzazione sia stato toccato e ora ci si stia indirizzando verso un mondo che tornerà a essere diviso in blocchi, purtroppo. La geopolitica è così tornata a essere preponderante, mentre durante tutta la mia carriera era diventata un fattore marginale nel fare business».
Non è più così?
«Oggi, qualsiasi manager d’azienda deve fare i conti con la geopolitica, perché quest’ultima fa sì che alcuni mercati diventino meno accessibili o meno convenienti di altri e investirvi comporti un rischio che non vale la pena correre. La catena del valore va accorciata e attività una volta locate in aree molto lontane, ora vengono spostate in zone più vicine o limitrofe: la pandemia ha dimostrato chiaramente le conseguenze di un’interruzione della filiera e i problemi enormi che si generano. Inoltre, avere a che fare con governi che, da un momento all’altro, possono cambiare la legislazione corrente e bloccare le esportazioni o applicare sanzioni è un aspetto molto serio che un manager, o un imprenditore, non può ignorare. Ahimè, diventeremo più locali e il mondo in cui ho vissuto è finito».
Ma l’esperienza che lei ha acquisito non rimane pur sempre valida anche in un diverso contesto globale?
«L’esperienza multiculturale serve, ma sono le dimensioni del mercato che si sono ristrette: il campo da gioco è diventato più piccolo. C’è molta difficoltà, adesso, a lavorare con alcuni paesi, quali la Cina e la Russia, e non credo che le cose potranno cambiare nel prossimo futuro perché il decoupling tra le democrazie occidentali e questi paesi autocratici è un dato acquisito: si è dinnanzi a un processo inevitabile».
Mi è più facile comprendere le ragioni della sua considerazione nei confronti della Russia, ma perché l’allarga anche alla Cina?
«C’è una tendenza chiarissima del Partito comunista cinese che è mettere il bastone tra le ruote alle aziende occidentali e ciò sta causando un’uscita degli investitori esteri dalla Cina, che è diventato un paese diverso da quello che conoscevo: si sta chiudendo su sé stesso e considera l’occidente un avversario. È molto difficile operare al suo interno, perché c’è un sistema giuridico che non supporta l’imprenditore straniero e il Partito fa di tutto per avvantaggiare i player locali. A mio parere, la Cina può essere considerata un mercato di sbocco, ma non uno in cui investire e creare basi produttive».
Ha ravvisato dei cambiamenti anche nel mercato americano?
«Gli Stati Uniti sono molto diversi rispetto a qualche anno fa. Ho sempre avuto una particolare predilezione per questo paese, che, per alcuni aspetti, è per me un punto di riferimento, ma è innegabile che sia diventata una nazione molto divisa. La società americana è spaccata, con un fossato enorme tra due schieramenti che si contrappongono: da un lato, i democratici, dall’altro, i repubblicani. In alcuni casi direi che ci sia quasi un’aria da guerra civile. Certamente, il mercato americano continua a essere molto interessante con i suoi 350 milioni di consumatori e credo che, per le aziende italiane del settore food, dove io opero, ci siano ancora numerose opportunità da cogliere. Tuttavia, non sono più gli Stati Uniti che conoscevo».
In Cina ci sono 1,4 miliardi di consumatori. Non trova la cosa interessante?
«Sì, per l’export, come le accennavo in precedenza, e credo ci sia ancora molto da fare. Vorrei fare però una precisazione sulle dimensioni del mercato, che non è misurabile in termini di popolazione, poiché alcuni prodotti sono indirizzati solo a una parte dei consumatori che hanno un reddito disponibile tale da potersi permettere prodotti made in Italy nel food. Inoltre, va ricordata la propensione dei consumatori cinesi a non acquistare determinati beni che sono ritenuti dannosi per la loro salute».
Lei opera però in un settore ipercompetitivo, il food & beverage, con la presenza di aziende che sono veri e propri colossi. Come si realizzano, in tale ambito, storie di successo?
«È molto complesso e devo dire che mi sono sempre stati dati compiti difficili, sin da giovane. Se analizziamo il mercato rispetto al modello delle cinque forze di Porter (modello utilizzabile dalle imprese per misurare la propria forza competitiva), emerge chiaramente una situazione addirittura ipercompetitiva. Il potere negoziale dei clienti, che sono le grandi catene internazionali e i discount, e dei fornitori è elevatissimo; la grande distribuzione ha conosciuto un processo di consolidamento, mentre l’industria del food & beverage è ancora molto frammentata, nonostante la presenza di grandi player. Le aziende di piccole-medie dimensioni rischiano così di essere schiacciate, sia dal lato dei clienti, sia da quello dei fornitori, così come è avvenuto nel 2022 con l’aumento delle materie prime e dei costi energetici, dove è stato necessario quasi un anno prima di poterli scaricare a valle. Non è un caso che i risultati aziendali di molti operatori del settore siano stati disastrosi. L’unica via, a mio avviso, percorribile è l’innovazione, di prodotto e di processo, e la competitività, che io chiamo kaizen. Queste sono le due leve che gli imprenditori devono quotidianamente utilizzare. Tuttavia, va detto che questo mercato è in crescita, soprattutto per chi gestisce il made in Italy, molto apprezzato all’estero, anche nei paesi lontani, dove con il prodotto acquistano anche il nostro stile di vita. La strada da percorrere è avere una strategia di differenziazione per essere diversi dagli altri, perché se si fosse misurati semplicemente sul prezzo sarebbe impossibile generare margini operativi».
Con mercati che stanno conoscendo una regionalizzazione, come si rende un marchio internazionale? C’è una contraddizione nei termini?
«Il mondo è grande comunque. Banalmente, se un marchio italiano si concentrasse sui paesi del blocco occidentale, ci sarebbe ugualmente talmente tanto da fare da essere costretti a operare diverse scelte in base alle risorse disponibili: per entrare, ad esempio, sul mercato americano, occorre fare consistenti investimenti, mentre su quello tedesco è necessaria una forte logistica. Avere una strategia significa fare delle scelte, che il mondo sia o non sia globalizzato e, comunque, è fondamentale avere un piano progressivo. E poi ci sono anche nuovi mercati da esplorare, quali quello africano. Mi rattrista il fatto che si sia tornati a una logica dei blocchi, che pensavo definitivamente superata, risultato di scelte compiute da persone che non sono più giovani e che stanno condizionando la vita delle generazioni future».
Lei ha avuto molte esperienze professionali: sono per lei continue sfide?
«Ogni esperienza è per me diversa e non vado a mutuare quanto sperimentato in precedenza. Penso che il problema della maggior parte delle persone di successo risieda proprio in quest’ultimo aspetto: pensare che esista una formula da replicare per ottenere gli stessi risultati. Infine, devo ammettere che sono un individuo che ama le sfide: dopo aver trascorso troppo tempo in un porto, mi piace muovermi verso nuovi lidi e prendere il mare. Credo che questo aspetto faccia parte della mia identità».
Dal suo punto di vista, come vede il futuro?
«Sono convinto che il periodo storico che stiamo vivendo sia una reazione a un processo di globalizzazione condotto in modo troppo veloce. Ciò ha suscitato diverse reazioni negative da parte di una fascia della popolazione, con implicazioni politiche e geopolitiche. Di fatto, l’errore commesso, anche da parte mia, è stato non avere reso tutti partecipi del processo in corso, lasciando indietro una parte di persone che si sono sentite impoverite, discriminate e perse. Il multiculturalismo, che fa parte della mia identità, è stato percepito come una recisione delle radici culturali e quindi, per alcuni, un atteggiamento da combattere. Ciononostante, sono convinto che la reazione che stiamo vedendo ora sia temporanea, perché il processo di globalizzazione non può essere fermato: siamo nel mezzo di un’onda di risucchio, che, prima o poi, dovrà infrangersi, anche se è difficile stimarne i tempi».