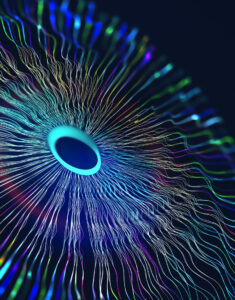Una stilografica verso i 200 anni
 «Immaginare il futuro di un’azienda centenaria per proiettarla verso i 200 anni è sicuramente un traguardo ambizioso, ma è anche un modo bello di immaginare che gli uomini possano lasciare una traccia, un segno, e che le nuove generazioni abbiano la possibilità di interpretare il nostro sogno e di proseguirlo nel tempo». Sono le parole di Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora, società italiana leader nella produzione di penne stilografiche. Dopo la laurea in economia ed esperienze manageriali in alcune importanti realtà, nel 1990 Cesare Verona entra nell’azienda guidata dal padre e nel 2011 assume la totale responsabilità della manifattura. Be Private lo ha incontrato e si è fatto raccontare come Aurora è diventata un marchio globale.
«Immaginare il futuro di un’azienda centenaria per proiettarla verso i 200 anni è sicuramente un traguardo ambizioso, ma è anche un modo bello di immaginare che gli uomini possano lasciare una traccia, un segno, e che le nuove generazioni abbiano la possibilità di interpretare il nostro sogno e di proseguirlo nel tempo». Sono le parole di Cesare Verona, presidente e amministratore delegato di Aurora, società italiana leader nella produzione di penne stilografiche. Dopo la laurea in economia ed esperienze manageriali in alcune importanti realtà, nel 1990 Cesare Verona entra nell’azienda guidata dal padre e nel 2011 assume la totale responsabilità della manifattura. Be Private lo ha incontrato e si è fatto raccontare come Aurora è diventata un marchio globale.
Da oltre 100 anni la sua famiglia è legata al segno ed è alla guida di un’impresa che oggi è considerata un’eccellenza del Made in Italy.
«Un’azienda alla quarta generazione, capofila nella produzione di strumenti di scrittura. Alla fine dell’800, il mio bisnonno, Cesare Verona, importò la prima macchina da scrivere (Remington) e proiettò il nostro paese verso un nuovo modo di comunicare. Abbiamo più di 100 anni ma, come amo dire, siamo entrati nei secondi prossimi 100 e non nel 102°. Sembra una sottigliezza, ma è un distinguo importante per dare un senso alla prospettiva del presente e del futuro. Guardiamo avanti, consci che avere una storia centenaria dà il privilegio di imparare dal passato e di vedere come, nonostante si siano fatti alcuni errori, vi abbiamo posto rimedio».
Ci racconta il successo della sua azienda?
«È una società al 100% di proprietà italiana. Abbiamo una lunga tradizione, ma abbiamo passato anche momenti difficili. Nel 2008 mio padre, a 81 anni, era a capo un’azienda allora pesantemente in perdita, con un Ebitda (margine operativo lordo) negativo a doppia cifra. Si era persa la rotta e, chiedendo consiglio a diverse persone, mi ero sentito rispondere che eravamo tecnicamente falliti e non avevamo alcuna speranza di sopravvivere. Io però continuavo a pensare che, in realtà, il nostro futuro avrebbe potuto conoscere una sorte diversa. A convincermi definitivamente fu il confronto con un conoscente amico-imprenditore che, per quanto giudicasse la situazione molto critica, mi incoraggiò ad andare avanti, perché aveva colto in me la determinazione e la forza necessarie per poterlo fare. Mi disse che la mia visione futura dell’azienda era talmente chiara che avrei dovuto proseguire per rispetto di chi era stato imprenditore prima di me, rispetto di me stesso e dei miei figli. E così ho fatto».
È stata una ristrutturazione complessa?
«Abbiamo lavorato tanto, con molto rigore, perché ristrutturare ha significato sì guardare agli sprechi, tagliare personale, ma anche innovare. È stato digitalizzato tutto il processo produttivo, è stata introdotta una lean production, abbiamo ricontrollato e riverificato tutti i nostri flussi: dal capitale circolante ai dati economici, finanziari e patrimoniali. Abbiamo cercato di dare una direzione agli uomini e alle donne (80% del personale) che lavorano con noi e di ridare l’orgoglio dell’appartenenza. Abbiamo rifocalizzato il business, fatto investimenti, aperto ai mercati e riposizionato il marchio. È stato un lavoro molto impegnativo, dove il nostro passato imprenditoriale ci ha sì aiutati, ma non è stato sufficiente per guardare al futuro. L’intuizione ci ha supportati e la passione è stata un ottimo carburante per avere successo. Ma la passione ha bisogno della determinazione, perché imprenditori appassionati che amano il loro lavoro e la loro azienda ce ne sono tanti, ma non basta. E poi occorre tanto spirito di sacrificio. Grazie a questi ingredienti è stato possibile raggiungere i risultati di oggi».
Qual è la situazione odierna?
«Continuiamo a investire: stiamo pensando di inserire alcuni robot collaborativi nella produzione e guardiamo ai big data. Ho ricevuto un’azienda che era 10 anni indietro rispetto a ciò che doveva essere e vorrei lasciarne una, alla quinta generazione, che è cinque anni avanti per potere gestire il quotidiano con più tranquillità e non avere l’assillo del conto economico e di pagare i fornitori e gli stipendi, come ho avuto io per un certo periodo. Non abbiamo mai delocalizzato, anche quando sembrava che fosse la strada che tutti gli imprenditori dovevano percorrere. Nel passato, ci sono stati confronti sul tema, ma la decisione di rimanere radicati nel territorio è stata dettata dal convincimento che la battaglia sul mercato si fa sul valore e non sul prezzo, sull’innovazione, sulla capacità di offrire qualcosa di bello e di ben fatto, ovvero i nostri prodotti. Io dicevo sempre a mio padre che dopo la Cina c’è il Vietnam e poi la Birmania poi il Buthan, poi c’è l’Africa, poi la luna e poi sono finiti i pianeti. Non si può continuare a rincorrere le cose, perché la rincorsa non porta da nessuna parte e ci sono imprenditori che hanno fatto scelte diverse dalle nostre e non sono più riusciti a tenere l’azienda. Per noi il territorio è importante: dietro una filiera ci sono aziende, fornitori che hanno un know how che deve essere mantenuto, perché genera ricchezza economica e permette di continuare a coltivare le competenze».
Quindi un forte senso di appartenenza al territorio
«Il nostro è un prodotto Made in Italy, fatto in Italia, e avere percorso questa strada, alla fine, ci ha dato ragione. Nella nostra azienda sventola una bandiera italiana, che alla sera si illumina. La nostra musica di attesa al telefono è l’inno di Mameli. Non è una posa la nostra, ma una decisione consapevole per ciò che rappresentiamo. Siamo una famiglia che si è impegnata per il territorio e abbiamo creato una fondazione, l’Officina della scrittura, che offre agli studenti, ai ragazzi , ai designer, agli architetti, agli appassionati e ai collezionisti un modo di pensare. L’azienda ha aperto le sue porte a visite esterne accogliendo circa 7–8 mila visitatori. Ci piacerebbe lasciare un segno alle nuove generazioni indicando come il mondo digitale possa convivere con uno diverso: quello della penna stilografica e degli strumenti di scrittura».
Ma come sposate la vostra artigianalità con i processi di innovazione?
«Rimaniamo sempre artigiani. Bisogna fare attenzione a mantenere quel giusto equilibrio tra la capacità del sapere fare e l’uso della tecnica per mantenere competitive le imprese, lasciando alle persone la possibilità di creare il valore, alleviandole dei lavori ripetitivi. Noi in azienda lo abbiamo fatto attraverso la digitalizzazione e, nella produzione, impieghiamo degli agv shuttle che vengono utilizzati, attraverso un tablet, per spostare i pezzi per realizzare i nostri prodotti. Bisogna usare la tecnologia rimanendo artigiani. Mi chiedo sempre qual è il livello di automazione e di investimenti tecnologici per riuscire a mantenere quell’anima artigiana che tiene vivo il Dna di un’impresa come la nostra. Ma, come sostiene Stefano Micelli in “Futuro artigiano”, non si deve tramandare da padre a figlio la manualità, bensì la capacità di stare sul mercato mantenendo la propria anima. Gli italiani e i francesi lo hanno capito molto bene e non è un caso che questi ultimi abbiano sì fatto molte acquisizioni in Italia, ma lasciandovi la produzione, perché hanno compreso che c’è un mix che non va rovinato e modificato. Il prodotto artigianale può convivere con la modernità e la digitalizzazione e il “fi-gital” può essere il giusto equilibrio».
La pandemia ha avuto forti impatti sulla vostra attività?
«Siamo passati indenni da quella difficile situazione, lasciando sul campo solo il 3,7% del nostro fatturato. Abbiamo sofferto poco rispetto ad altri comparti, forse perché eravamo già attrezzati a sfide diverse e anche perché penne e pennarelli sono “beni della nazione” per cui ci hanno dato il privilegio di non chiudere. Oggi, il nostro fatturato sta crescendo del 30-40% e il portafoglio ordini è aumentato del 60-70%. Ciò dimostra che, oltre a non avere preoccupazioni nell’immediato, abbiamo trovato molti prodotti giusti che ci hanno permesso di essere presenti sul mercato in modo importante. Come dicevo prima, la nostra azienda è partita da una situazione difficile nel 2008, ma oggi l’Ebitda è positivo e a doppia cifra, di cui la prima è un due. Certo, non siamo gli unici nel segmento del lusso e dei prodotti ad alto valore simbolico, ma abbiamo un margine operativo lordo simile a quello di Ferrari e possiamo ritenerci soddisfatti. Ci siamo dotati di una struttura commerciale molto forte, guidata dalla dottoressa Edolinda Di Fonzo, entrata in azienda nel 2008. Infatti, sono sempre stato convinto, come dicevo a mio padre, che un’impresa che dipende da un solo mercato è debole, a rischio e non ha futuro. Siamo passati da un peso delle esportazioni del 3% all’attuale 80%: 25% in Europa, circa il 30% in Usa e il restante in Medio Oriente e Far East».
E per il futuro?
«Abbiamo lanciato un piano quinquennale che prevede di raddoppiare il fatturato. A testimonianza della fiducia che abbiamo nel nostro Paese, il 14 ottobre abbiamo aperto la seconda boutique monomarca in Via San Pietro all’Orto a Milano, dopo quella di Roma di Via del Babbuino. Forse stiamo andando un po’ controcorrente, ma continuiamo a credere che il mondo del retail fisico possa continuare a convivere con il digitale e stiamo cercando di trovare la nostra strada, che magari non è quella che seguiranno tutti, ma siamo convinti che sia importante fornire ai nostri clienti un’esperienza di vendita acquisto differente».
Che cosa pensa della situazione economica italiana?
«L’Italia è un paese complicato e complesso dove fare impresa. Ma siccome penso che gli imprenditori italiani siano mediamente più bravi degli altri, il fatto di riuscire a sopravvivere in questa complessità dà una resilienza diversa. La riflessione che faccio sull’Italia è la seguente: siamo un Paese che non ha materie prime, abbiamo perso gran parte delle battaglie strategiche, dall’avionica all’auto e alla chimica, per cui dobbiamo importare materiali, trasformarli al meglio possibile e creare prodotti, anche esteticamente belli, da vendere in giro per il mondo. L’Italia pesa circa il 3% dell’output mondiale, ma il lusso vale il 12-15% ed è una componente importante del tessuto economico. Certo, la capacità degli italiani è fare le cose belle, ma sappiamo anche farle bene. Sappiamo creare, inventare, innovare, vedere, disegnare, ma soprattutto sappiamo fare oggetti che funzionano e lo vediamo in tutta una serie di comparti oltre a quello del lusso, dove ci viene dato credito. Ciò significa che il sistema Paese ha guadagnato credibilità : siamo una nazione migliore rispetto a vent’anni fa. Ora l’Italia cresce a tassi di Pil del 6%, stiamo facendo bene e non siamo più il fanalino di coda dell’Europa: è un segnale importante. Inoltre c’è anche il Pnrr ed è un’occasione unica da cogliere e il mio augurio è che i soldi siano spesi bene, soprattutto in infrastrutture di cui il nostro Paese è carente e ha estremo bisogno. Non so se si sia di fronte a una svolta, ma stiamo attraversando un periodo favorevole: dalle vittorie in campo musicale a quelle sportive, sino ai successi in campo economico. Noi, come Aurora, guardiamo con ragionato e ragionevole ottimismo al futuro. Non so quante siano le aziende che si esprimono in questo modo, ma siamo sereni nel dire che abbiamo quattro o cinque anni, spero e penso belli, da affrontare».